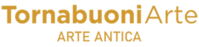ANDREA DELLA ROBBIA
Firenze, 1435-1525
Tabernacolo Eucaristico
data: 1440 circa
terracotta invetriata, cm 121x71x10
Questo raro tabernacolo eucaristico parietale è stato ricondotto da Giancarlo Gentilini ad Andrea della Robbia, tra i maggiori scultori del suo tempo, nipote del celebre Luca.
Nel suo dettagliato scritto dedicato all’opera, lo studioso descrive minuziosamente questa “significativa testimonianza del versatile ingegno creativo di Andrea”, composta un tempo di cinque elementi (assente il gradino), di cui quattro ancora presenti, inclusa la cimasa (priva del fregio). Il corpo principale finge un vano architettonico classicizzante con volta a botte e lacunari nei quali compaiono due angeli adoranti e la colomba dello Spirito Santo. Al centro sono presenti due aperture, il vano dell’ostia consacrata – un tempo protetto da una porticina solitamente bronzea – e un oculo. Ai lati si trovano le due paraste corinzie, decorate con tralci vegetali composti da pine, mele cotogne e aranci. Completa l’opera una cimasa ad arco dominata dal busto del Redentore, effigiato come un busto romano entro una nicchia a conchiglia di matrice classica.
Come precisato da Gentilini questa tipologia di tabernacolo, col suo repertorio iconografico, trova “puntualissimi riscontri in altre edicole per il Sacramento di analoghe dimensioni da tempo concordemente riferite dalla critica ad Andrea della Robbia e alla sua bottega”. Andrea della Robbia, partendo da soluzioni sperimentate da autori quali Bernardo Rossellino e Desiderio da Settignano, realizzò numerosi esempi di tabernacoli eucaristici parietali. Tra questi, eccellono per monumentalità e complessità quelli conservati nella badia di Sansepolcro, nel duomo di Barga e nella chiesa fiorentina dei Santi Apostoli, compiuti tra fine del XV e il secondo decennio del XVI secolo.
Lo studioso segnala, come confronto particolarmente calzante con il tabernacolo in esame, due esemplari conservati a San Pietro ad Anchiano presso Borgo a Mozzano e a Cappella, in territorio lucchese. Questi sono caratterizzati, oltre che da un similare repertorio decorativo, da “angeli in posizione dinamica, incedenti”, una peculiarità che sembra appartenere all’artista intorno al primo lustro del secolo.