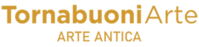BERNARDINO DI BETTO detto IL PINTURICCHIO, scuola di
Perugia, 1452 circa – Siena, 1513
Incontro dei Re Magi
tempera su tela, cm 265×158
Questa grande tela riproduce, entro una cornice architettonica classicheggiante, un episodio del lungo viaggio che condurrà i tre Re Magi a raggiungere Gesù appena nato per offrirgli i loro preziosi doni.
L’esaustivo studio di Expertise – Periti d’Arte Associati, che accompagna l’opera, sottolinea come l’inconsueta rappresentazione, che si riferisce “all’incontro dei tre Re e alla preparazione del corteo per recarsi a rendere omaggio al Salvatore”, narri un evento non descritto nei Vangeli canonici, e che “quindi le fonti iconografiche [siano] da ricercare sui testi apocrifi e nel Vangelo armeno dell’Infanzia”. Il gusto fiabesco, i fastosi costumi orientaleggianti, l’affollamento dei personaggi con criteri ancora medievali di scansione spaziale, ricordano le ben note raffigurazioni di questo soggetto. Tra queste menzioniamo: la celebre Pala Strozzi di Gentile da Fabriano per San Niccolò d’Oltrarno, ora agli Uffizi, e la Cappella dei Magi, affrescata da Benozzo Gozzoli nel fiorentino Palazzo Medici intorno alla metà del quindicesimo secolo.
Come rilevato nello studio, tuttavia, la fonte alla quale fa riferimento questa figurazione è più tarda. La scena è organizzata in maniera diversa, tanto che il modello è rappresentato senza dubbio dagli affreschi di Pinturicchio e della sua cerchia alla Libreria Piccolomini di Siena, realizzati nel primo lustro del Cinquecento per narrare le storie di Pio II Piccolomini. In particolare, la cornice architettonica, nella decorazione a grottesca dei pilastrini e nei capitelli, sembra costituire una citazione del testo figurativo senese. Tuttavia, particolare degno di nota, la prospettiva con cui è rappresentato l’arcone non è centrale, come nell’affresco di riferimento, ma tiene conto di una visione laterale. Un dettaglio che ci rivela la sua appartenenza, in origine, ad un ciclo di tele, evidentemente dedicate al viaggio dei Magi, e che, con grande probabilità culminava al centro di un vasto salone in una “Adorazione del Bambino”.
L’intrigante questione dell’individuazione dell’autore, partendo dall’impresa del grande maestro umbro, è tuttora aperta. Al carattere centro italiano dell’opera sembrano unirsi, nel castello in alto, delineato da una nitida luce adamantina, reminiscenze settentrionali.
Pubblicazioni:
“Oltre. In viaggio con cercatori, fuggitivi, pellegrini”, catalogo di mostra a cura di don Alessio Geretti, Casa delle Esposizioni di Illegio, Allemandi, Torino, 2016, p.155.