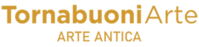ANNIBALE CARRACCI, cerchia di
Bologna, 1560 – Roma, 1609
Santa Margherita d’Antiochia
olio su tela, cm 76×61
Santa Margherita, la cui esistenza storica non è mai stata attestata, nacque da genitori pagani ad Antiochia di Pisidia, nell’Anatolia allora sotto il dominio di Diocleziano, e venne nascostamente educata alla fede cristiana dalla nutrice a cui il padre l’aveva affidata dopo la precoce morte della madre. Una volta cresciuta, la fanciulla rivelò al padre la sua fede e lui la cacciò di casa. Tornata a vivere dalla nutrice, un giorno, mentre pascolava il gregge, venne notata per la sua bellezza dal prefetto di Antiochia, Olibrio, che se ne invaghì e si offrì di sposarla. Margherita respinse la proposta dichiarandosi sposa di Cristo, così Olibrio, anche per vendicarsi del rifiuto, la fece prima imprigionare poi torturare con l’accusa di essere cristiana. Nel buio della cella, una notte, il demonio apparve alla giovane sotto forma di drago inghiottendola, ma lei, armata della croce, gli lacerò il ventre e ne uscì trionfante. Un secondo demonio le apparve ma nemmeno questo riuscì a impressionarla. Il giorno seguente Olibrio, nel tentativo di scalfirne la fede per l’ennesima volta, la fece torturare con fiaccole ardenti che le lacerarono la pelle dei fianchi, ma comprendendo che nessun supplizio sarebbe riuscito a farle rinnegare Cristo decise infine di decapitarla.
Il quadro che presentiamo è liberamente ispirato al dipinto di Annibale Carracci col medesimo soggetto – però a figura intera – che l’artista dipinse nel 1599 per la cappella di Gabriele Bombasi nella chiesa romana di Santa Caterina dei Funari. Il letterato, originario di Reggio Emilia, chiese esplicitamente che la figura della martire fosse simile a quella di Santa Caterina nella cosiddetta Madonna di San Luca, dipinta da Annibale solo pochi anni prima (1592-95) per la cappella dei Notai – di cui l’evangelista era patrono – proprio nella cattedrale reggiana (l’opera è oggi conservata al Louvre in seguito alle spoliazioni napoleoniche del 1797).
Il quadro romano rappresentò un momento di svolta nell’arte, un superamento della maniera e della sua rappresentazione solenne tanto che la sua carica innovativa fu percepita non appena fu esposto. Nel 1672 Pietro Bellori scriverà in merito all’evento «Collocato il quadro sull’altare per la novità vi concorsero i pittori e fra vari discorsi loro, Michel Angelo da Caravaggio, dopo essersi fermato lungamente a riguardarlo, si rivolse e disse ‘Mi rallegro che al mio tempo veggo pur un pittore!».
Francesco Albani, allievo del Carracci, rivolgendosi ai suoi alunni diceva che se avessero voluto imparare a dipingere sarebbero dovuti correre a Santa Caterina « Horsù dipingete allegramente indirizandovi a quel bellissimo colorito della Santa Margherita à S.ta Caterina de funari di mano di Annibale Carrazzi quella che il Caravaggio ci moriva sopra in riguardarla»
Sebbene si tratti di un soggetto sacro, addirittura di una martire, la protagonista della tela non ha infatti nulla di ieratico ne’ patetico, anzi, la santa è raffigurata in una posa talmente naturale da apparire quasi disinvolta mentre, appoggiata a un piedistallo marmoreo, volge lo sguardo dritto allo spettatore e con la mano destra indica in alto.
Il successo riscosso dal quadro venne sottolineato anche dall’incisione a bulino che ne fu tratta dall’olandese Cornelis Bloemaert il Giovane, poi riprodotta in numerose stampe che contribuirono ulteriormente a veicolare la fama del dipinto e la sua carica rivoluzionaria.